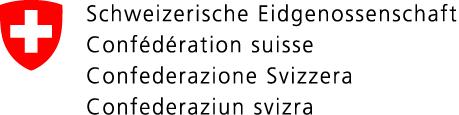Il metano e il protossido di azoto sono gas serra prodotti da processi biochimici che avvengono anche negli ecosistemi naturali. Vengono generati anche nell’ambito della produzione agricola, che ne può aumentare notevolmente le emissioni. Ma che effetto hanno questi gas, come vengono prodotti e come si possono evitare?
Secondo l’inventario nazionale delle emissioni di gas serra, al settore agricolo è imputabile circa il 14 per cento delle emissioni di gas serra della Svizzera (anno di riferimento 2022; UFAM 2024). Il settore agricolo è qui inteso secondo la definizione del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) utilizzata per gli inventari nazionali dei gas serra (IPCC 2006). Se i limiti del settore fossero impostati diversamente, questo porterebbe a valori leggermente diversi (in genere superiori).

© BAFU
Secondo l’inventario nazionale dei gas serra, l’agricoltura è responsabile dell’86 per cento delle emissioni di metano (CH4) e del 64 per cento di quelle di protossido di azoto (N2O) in Svizzera (UFAM 2024).

© BAFU

© Agroscope
Nell'ambito dell'Accordo di Parigi, le Parti hanno stabilito un'unità di conversione comune per i vari gas serra (The global warming potential GWP, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, 2018). Per il rendiconto ai sensi dell'UNFCCC devono essere utilizzati i valori del potenziale di riscaldamento globale (GWP100) del quinto rapporto di valutazione dell’IPCC (IPCC, 2013). Secondo il rapporto, un chilogrammo di metano ha un potenziale di riscaldamento globale 28 volte superiore rispetto a un chilogrammo di anidride carbonica (CO2) su un orizzonte temporale di 100 anni. Il metano viene prodotto principalmente dall’allevamento di ruminanti da latte e da carne (bovini, ovini e caprini) durante la digestione di alimenti ricchi di fibre nel rumine e durante lo stoccaggio dei liquami aziendali. L’effetto del protossido di azoto in termini di riscaldamento climatico è circa 265 volte superiore rispetto a quello dell’anidride carbonica. Il protossido di azoto viene prodotto durante lo stoccaggio dei concimi organici aziendali, ma soprattutto durante lo spandimento dei concimi azotati.
Dal 1990 al 2004 le emissioni di metano sono diminuite dell’8,5 per cento (UFAM 2024). Dopo il 2004 le emissioni di metano sono aumentate brevemente, prima di registrare un’inversione di tendenza. Nel 2022 le emissioni di metano erano inferiori del 10 per cento circa rispetto ai livelli del 1990. Le emissioni di protossido di azoto mostrano un andamento simile, anche se la diminuzione fino al 2004 è stata significativamente maggiore, pari al 20 per cento. A partire dal 2004, invece, sono diminuite appena, e nel 2022 erano inferiori del 23 per cento rispetto ai livelli del 1990.

© BAFU
La riduzione delle emissioni di metano è dovuta principalmente al miglioramento delle pratiche di allevamento e dell’efficienza nella produzione. In particolare, l’aumento del contenuto energetico delle razioni e razioni più bilanciate hanno portato a un incremento dell’efficienza alimentare. Questo ha dunque permesso di ridurre gli effettivi di animali mantenendo una produzione costante o addirittura lievemente maggiore. Infatti, una vacca da latte oggi, nonostante emetta il 21 per cento in più di metano ed espella l'11 per cento di azoto in più, produce in media circa il 48 per cento di latte in più rispetto a trent’anni fa. Le emissioni per ogni litro di latte sono quindi diminuite di quasi un quinto (UFAM 2024).
L’introduzione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) all’inizio degli anni Novanta ha permesso di ridurre le quantità di azoto utilizzate (concimi aziendali e non). Ciò ha portato a una notevole diminuzione delle emissioni di protossido di azoto, con un conseguente significativo aumento dell’efficienza di uso dell’azoto.
Il miglioramento dell’efficienza sottostà ad alcuni limiti biofisici, sia in termini di aumento della produzione di latte che di efficienza di uso dell’azoto. Sebbene siano ancora possibili ulteriori progressi, è sempre più difficile ottenerli. Di conseguenza, negli ultimi 10 anni sono stati compiuti pochi ulteriori passi avanti.
A conti fatti, non esistono singole misure con un effetto di riduzione superiore al 20 per cento. Tuttavia, è possibile ottenere riduzioni importanti con una combinazione di misure minori (Bretscher et al., 2018), tra cui per esempio:
- allevamento per una produzione efficiente e adeguata alle condizioni locali e contemporaneamente a basse emissioni di metano,
- ottimizzazione delle razioni e impiego di additivi per mangimi,
- vacche sane, produttive e longeve,
- gestione della mandria (fertilità, intervallo interparto, adeguato rapporto tra razze da latte e da carne),
- stoccaggio dei concimi aziendali a basse emissioni (copertura, impianto di biogas).
L’attuazione di molteplici misure risulta però spesso impegnativa per le aziende svizzere e rappresenta una sfida importante; ostacoli organizzativi e strutturali, costi elevati e mancanza di know-how possono limitare l’implementazione di ulteriori misure atte all’effettiva riduzione di emissioni, nonostante questa sia teoricamente possibile (ad es. Zosso et al. 2024).

© Agroscope
Una inclusione nella razione di piante naturalmente ricche di polifenoli, in particolare di tannini, consente di ridurre le emissioni di metano. Tuttavia, la quantità richiesta di tali piante è di solito nettamente superiore a quella realisticamente ottenibile.
Inoltre, i ruminanti potrebbero essere alimentati con semi di lino estrusi o altri alimenti grassi, che possono ridurre la produzione di metano nel rumine. Ciononostante, per ottenere una riduzione significativa delle emissioni, solitamente servirebbero quantitativi elevati, rendendo dunque queste misure economicamente poco attrattive. Inoltre, la coltivazione di semi di lino per le razioni comporta un conflitto di obiettivi in termini di fabbisogno di superfici destinate all’alimentazione umana e a quella animale.
Anche diversi additivi a base di oli essenziali e altri estratti vegetali potrebbero ridurre le emissioni di metano e/o aumentare l'efficienza di foraggiamento. Finora, tuttavia, una riduzione significativa e duratura è stata dimostrata solo in pochi casi.
Le emissioni di metano possono essere ridotte in modo significativo con determinati additivi sintetici per i foraggi (ad es. il 3-nitroossipropanolo, abbr. 3-NOP). L’efficacia del 3-NOP nella riduzione del metano è stata dimostrata in numerosi studi. Tuttavia, anche in questo caso mancano studi affidabili a lungo termine. Ci sono anche riserve sulla trasferibilità dei risultati della ricerca alle razze e ai sistemi di produzione basati sulle superfici inerbite tipici della Svizzera. Per ottenere l’effetto desiderato, attualmente il 3-NOP può essere effettivamente utilizzato solo per le razioni miste in caso di stabulazione.
Con un rapporto equilibrato tra proteine ed energia nella razione, è possibile limitare l’escrezione di azoto e quindi limitarne le emissioni dai concimi aziendali. Ciò può contribuire ad aumentare l’efficienza di uso dell’azoto e a ridurre le emissioni di protossido di azoto (Schrade et al., 2023). Un indicatore adatto e facilmente individuabile dell’escrezione di azoto dalle vacche è il tasso di urea nel latte. Si raccomanda un'attenta pianificazione del foraggiamento.
Determinati additivi possono anche inibire l’attività dei microrganismi ruminali utili, compromettendo la digestione e l’utilizzo ottimali delle risorse foraggere naturali, in particolare della fibra di erba e di fieno. Questo può ridurre l’efficienza dell’animale, con il risultato che la riduzione delle emissioni di metano e protossido di azoto per unità di prodotto (litro di latte o chilo di carne) viene vanificata dalla diminuzione della produttività. Tali aspetti sono di solito accuratamente testati tramite studi nutrizionali, prima che un additivo venga raccomandato per l'uso nella pratica. In ogni caso, è necessario assicurarsi che il dosaggio sia accurato, oltre a monitorare costantemente i parametri di produzione degli animali.
I ruminanti emettono metano per natura. L'aumento del numero di ruminanti a livello mondiale, soprattutto negli ultimi 200 anni, ha contribuito a un forte incremento della concentrazione di metano nell'atmosfera e quindi a un aumento della temperatura globale (Reisinger e Clark, 2018). Se le emissioni globali di metano rimangono costanti, la temperatura globale aumenterà solo di poco, data la breve permanenza del metano in atmosfera. Allo stesso tempo, però, un "effetto di raffreddamento" rapido ed efficace non è possibile finché le emissioni non vengono ridotte. Inoltre, l'intensa produzione di alimenti concentrati e l'uso di concimi azotati contribuiscono in modo significativo alle emissioni di anidride carbonica e protossido di azoto.
L'estensione e le modalità dell'allevamento odierno sono una conseguenza dello sviluppo storico del sistema agrario e alimentare globale. Non possono essere quindi attribuite responsabilità a singoli attori. Allo stesso tempo, tuttavia, tutti gli attori hanno la responsabilità specifica di contribuire alla soluzione del problema climatico.
In linea di principio, i ruminanti dovrebbero essere allevati principalmente con un'alimentazione a base di foraggio prodotto su prati permanenti non adatti alla campicoltura e dovrebbero valorizzare anche i sottoprodotti della produzione di derrate alimentari. In questo modo si utilizzerebbero risorse accessibili solo a loro. Le superfici coltive dovrebbero essere preferibilmente destinate alla produzione di alimenti per il consumo umano diretto (Consiglio federale svizzero, 2022). Usi alternativi (come la produzione di foraggio) sono ammessi se necessari per la fertilità del suolo nell'ambito della rotazione delle colture (Consiglio federale svizzero, 2022). Nel contesto delle emissioni di gas serra, va considerato l'importante ruolo nella rotazione colturale dei prati seminati nel preservare il tenore di humus, cioè lo stock di carbonio (Guillaume et al., 2022). In Svizzera, questa strategia comporterebbe una riduzione del numero di ruminanti rispetto allo stato attuale. In questo modo, si verificherebbe sì un leggero aumento delle emissioni di metano per litro di latte, ma le emissioni totali risulterebbero comunque inferiori grazie al minor numero di animali (ad es. Schader et al., 2015). È inoltre possibile preservare gli stock di carbonio relativamente elevati nel suolo dei prati permanenti. Un uso ragionevole dei letami aziendali, necessario per il bilancio dell'humus del suolo, e la valorizzazione dei sottoprodotti dell’agricoltura, richiederanno ancora una collaborazione tra allevamento di ruminanti e campicoltura.

© Agroscope
I diversi alimenti hanno impronte di gas serra molto diverse (Poore and Nemecek, 2021). L'impronta di gas serra prodotta dagli alimenti di origine animale, in particolare della carne di ruminanti, in genere è di molte volte superiore a quella dei prodotti vegetali.
C’è quindi un discreto margine anche per l’azione di consumatrici e consumatori che, con la loro alimentazione, possono influenzare in modo significativo la loro impronta alimentare. Con una dieta conforme alla piramide alimentare, in Svizzera l’impronta media di gas serra legata all’alimentazione potrebbe essere praticamente dimezzata (Zimmermann et al., 2017).

La riduzione degli sprechi alimentari (food waste) costituirebbe un altro contributo importante per la protezione del clima all’interno del sistema alimentare.
Inoltre, si dovrebbe promuovere il consumo di prodotti stagionali e locali per evitare i trasporti a lunga distanza (compreso lo stoccaggio e la refrigerazione) e per ridurre la produzione di alimenti dannosi per il clima in altre regioni del mondo.

© sge-ssn.ch, blv.admin.ch / 2024
Fonti
Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, Deutschland:
https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-verstehen/haetten-sies-gewusst/tierhaltung/wie-viel-milch-geben-schafe-und-ziegen
FOEN 2025: Switzerland’s Greenhouse Gas Inventory 1990–2023: National Inventory Document and reporting tables (CRF). Submission of April 2025 under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Federal Office for the Environment, Bern.
www.climatereporting.ch
Guillaume, T., Makowski, D., Libohova, Z., Elfouki, S., Fontana, M., Leifeld, J., ... & Sinaj, S. (2022). Carbon storage in agricultural topsoils and subsoils is promoted by including temporary grasslands into the crop rotation. Geoderma, 422, 115937.
Hegarty, R.S., Passetti, R.A.C., Dittmer, K.M., Wang, Y., Shelton, S., Emmet-Booth, J., Wollenberg, E., McAllister, T., Leahy, S., Beauchemin, K., Gurwick, N. 2021
An evaluation of emerging feed additives to reduce methane emissions from livestock.
2021 Edition 1. A report coordinated by Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS), New Zealand Agricultural Greenhouse Gas Research Centre (NZAGRC), Global Research Alliance (GRA).
IPCC 2006: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Intergovernmental Panel on Climate Change.
www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp.
IPCC 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)
IPCC 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
DOI: 10.1017/9781009157896
Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung 2050
https://www.blw.admin.ch/de/klimastrategie-landwirtschaft-und-ernaehrung-2050
Reisinger, A., Clark, H. 2018: How much do direct livestock emissions actually contribute to global warming? Global Change Biology, Vol: 24/4: 1749-1761. doi:10.1111/gcb.13975
Schader, C., Muller, A., Scialabba, N. E.-H., Hecht, J., Isensee, A., Erb, K.-H., Smith, P., Makkar, H. P. S., Klocke, P., Leiber, F., Schwegler, P., Stolze, M., Niggli, U. 2015: Impacts of feeding less food-competing feedstuffs to livestock on global food system sustainability. Journal of The Royal Society Interface, Vol: 12/113: 10.https://doi.org/1098/rsif.2015.0891
Schrade, S., Zeyer, K., Mohn, J., Zähner, M. 2023: Effect of diets with different crude protein levels on ammnonia and greenhouse gas emissions from a naturally ventilated dairy housing, Science of the Total Environment, Vol. 896. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165027
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, Die Schweizer Lebensmittelpyramide - ausgewogene Ernährung
Schweizerischer Bundesrat, 2022: Zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik. Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate 20.3931 der WAK-S vom 20. August 2020 und 21.3015 der WAK-N vom 2. Februar 2021.
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72187.pdf
UNFCCC 2018: Decision 18/CMA.1: Modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and support referred to in Article 13 of the Paris Agreement.
https://unfccc.int/resource/tet/0/00mpg.pdf
Contatto
Informazioni complementari
Ultima modifica 18.07.2025